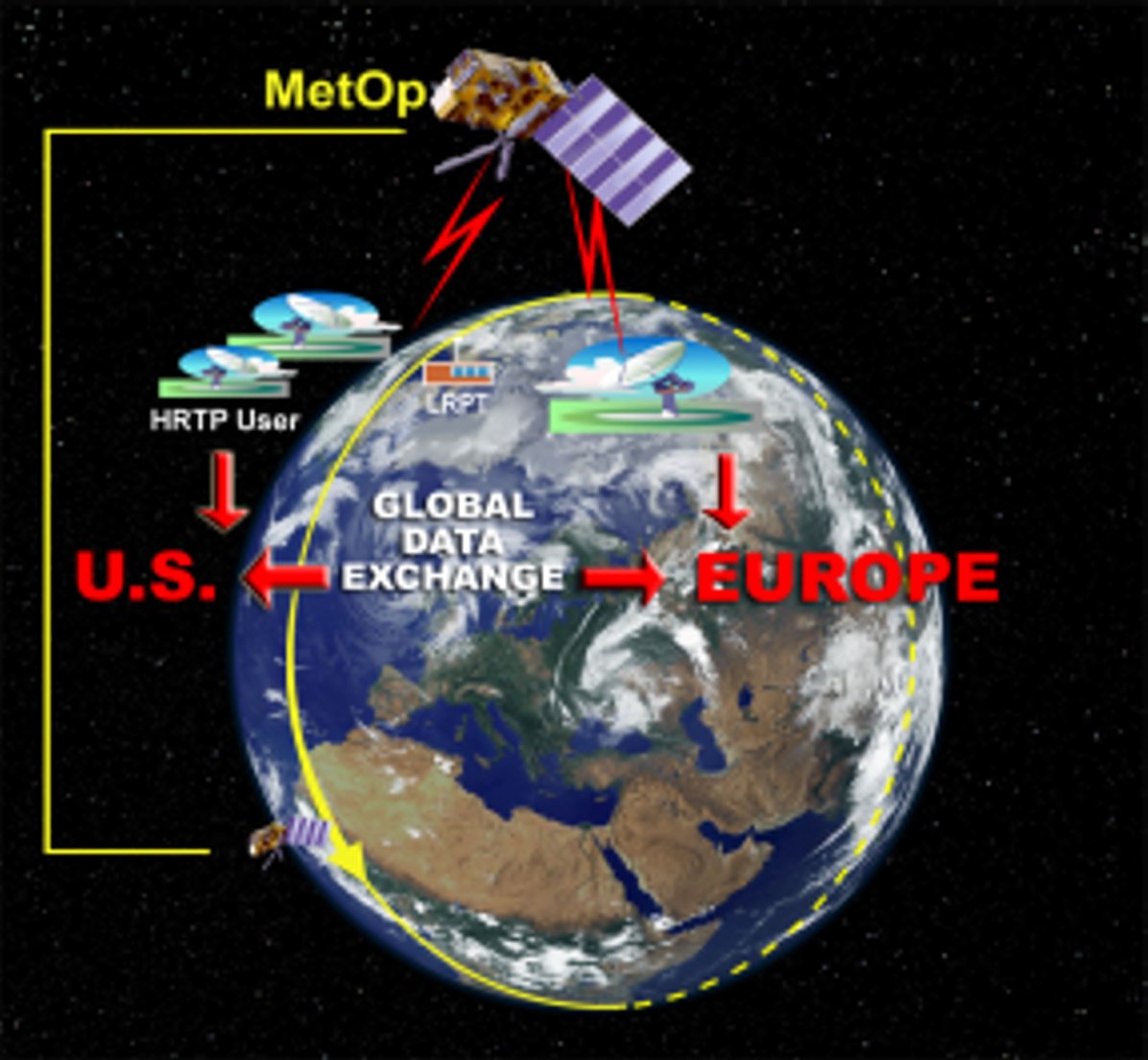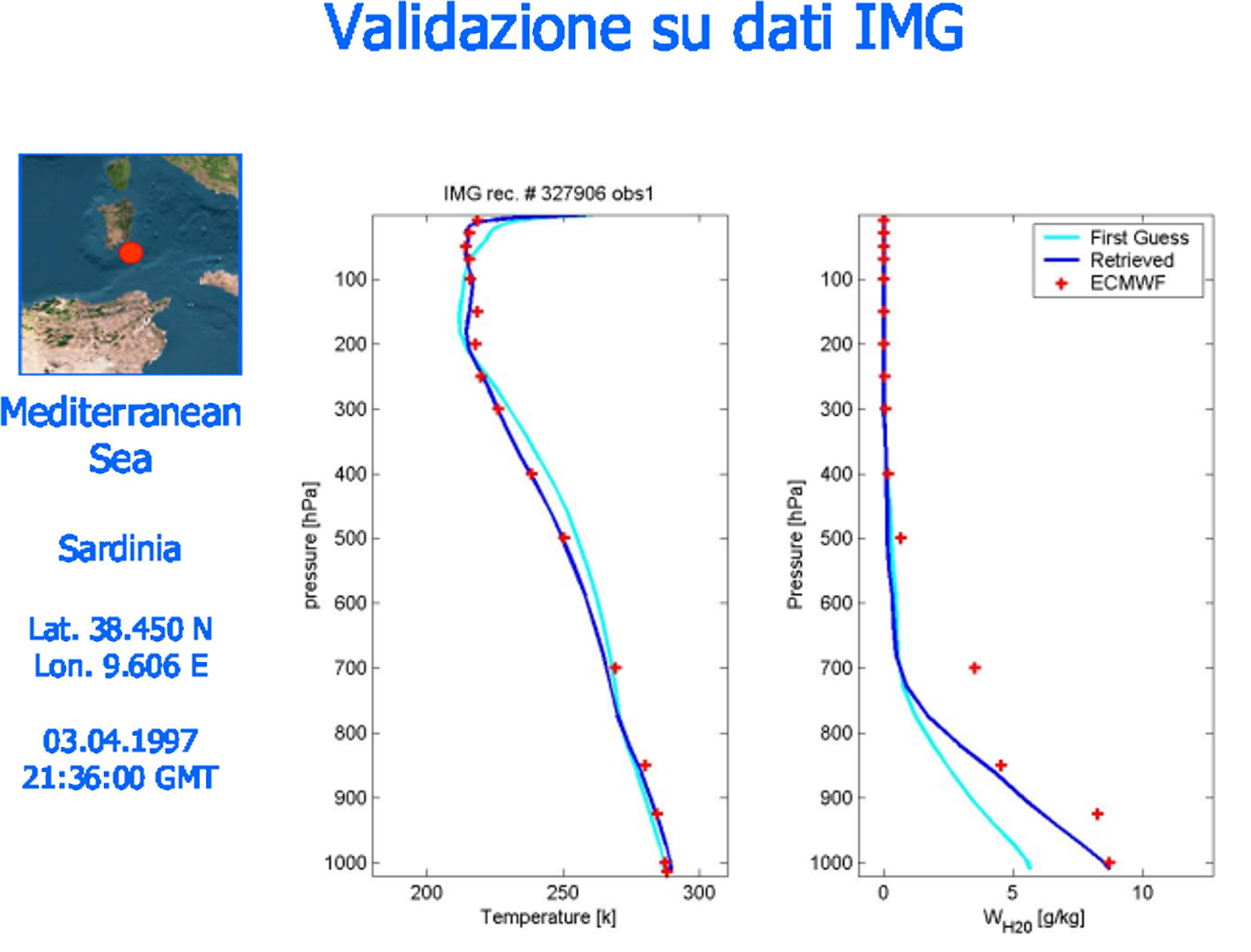"I satelliti stanno invadendo i nostri cieli". Questa frase a prima vista
potrebbe rappresentare solo un luogo comune; in effetti riassume una
poderosa realtà che permea (in modo talvolta inquietante) la vita
quotidiana di ciascuno e che coinvolge sia i paesi fortemente
industrializzati, sia quelli che aspirano a diventarlo. Il motivo cardine
è che il satellite risulta lo strumento più a basso costo in grado
di "fotografare" o "informare" l'intero globo terrestre (incluso oceani,
aree isolate, poli e quant'altro di più impervio si possa immaginare sul
pianeta; vedi Figura 1).
Una delle applicazioni più importanti del satellite è l'osservazione di
parametri geofisici terrestri, quali la temperatura ed il contenuto di
acqua lungo la colonna atmosferica: la loro misura accurata è considerata
uno strumento importante per migliorare ed estendere nel tempo
l'affidabilità delle previsioni meteorologiche, attualmente limitata a
circa 3 giorni. Il nodo cruciale delle applicazioni satellitari è che per
sua definizione il satellite non è in grado di effettuare misure DIRETTE
di molte grandezze geofisiche (per esempio non è possibile estendere dal
satellite fino alla superficie terrestre un filo lungo il quale un
ipotetico termometro registri la temperatura). Risulta necessario allora
ricorrere a misure INDIRETTE delle grandezze: si misurano cioè da
satellite altri parametri da cui le grandezze geofisiche richieste
dipendano e da essi si cerca di conoscere il valore delle grandezze
geofisiche. Dal punto di vista matematico si dice che si risolve un
problema INVERSO (per inciso, l'ordine invertito dei caratteri del titolo
testimonia il tipo di problema matematico).
L'Istituto per le Applicazioni del Calcolo 'Mauro Picone' è impegnato da
diversi anni nella risoluzione di tale problema in una collaborazione che
vede coinvolti il Dipartimento di Ingegneria e Fisica Ambientale
dell'Università della Basilicata e l'Istituto per le Metodologie di
Analisi Ambientale del CNR su progetti finanziati o sponsorizzati dalle
principali Agenzie Spaziali Internazionali (l'Agenzia Spaziale Italiana,
l'Agenzia Spaziale Europea, l'Organizzazione Europea per lo sfruttamento
dei satelliti meteorologici, l'Agenzia Spaziale Giapponese).
Lo strumento posto su satellite è l'interferometro di Michelson, che
misura la trasformata (coseno) di Fourier della radianza emessa dalla
Terra, che a sua volta dipende dai parametri geofisici cercati. Il modello
matematico che descrive l'intero fenomeno è costituito dall'equazione di
trasferimento radiativo in atmosfera, il cui problema inverso è stato il
principale oggetto delle ricerche. Una particolare formulazione del
modello che riduce al minimo le approssimazioni numeriche e lo sviluppo di
metodi efficienti ed accurati per la risoluzione numerica hanno portato
allo sviluppo di un codice di calcolo accurato e sufficientemente veloce
(in Figura 3 è mostrato il logo del modello di trasferimento radiativo
diretto veloce).
Il metodo è stato validato con successo sui dati misurati
dall'interferometro IMG dell'Agenzia Spaziale Giapponese (vedi Figura 2) e
costituisce il riferimento per la progettazione di interferometri di nuova
generazione, quale lo IASI, inizialmente sviluppato dall'industria e dalla
ricerca italiana ed in seguito divenuto progetto internazionale.
Immagini: